martedì 6 ottobre 2009
Racconti: La Città della Convenienza
[Pdf]
La città della convenienza sorge al centro di un deserto circolare e piano. Ampie, interminabili autostrade attraversano le distese sabbiose. Sono linee d’asfalto incandescenti e dipanate a raggiera lungo i punti cardinali assodati e supposte. Tutte convergono tutte nel grande anello che circonda la città della convenienza. Il pedaggio è modico.
Le origini della città sono dimenticate, quelle del deserto, sconosciute. Generalmente si attribuisce la paternità del deserto all’occhio infuocato di Dio, e quella della città all’ingegno dell’uomo. Ma non manca chi suppone che sia stato l’uomo a creare il deserto, la città, Dio. Si mormora inoltre che la città abbia spianato il deserto attorno a sé nel corso dei secoli.
La città della convenienza è un groviglio urlante di prezzi ed asfalto, panchine verdi scrostate davanti a vetrine scintillanti, parcheggi sotterranei, bancarelle, aria condizionata. Gli altoparlanti sono installati sotto i tombini e sopra i lampioni, dietro le luci dei semafori, sui tetti dei tram che passano sferragliando. Alcuni quartieri periferici non sono ancora raggiunti dall’impianto; quelle strade sono allora battute da uomini sandwich che urlano a squarciagola e si fustigano impietosamente il petto fino a stramazzare al suolo.
Che prezzi! È la città della convenienza. Qui il tuo danaro ha valore, qui puoi sempre risparmiare, sconti saldi offerte a volontà, non perdere l’opportunità, prezzi, ma che prezzi, prezzi bassi prezzi pazzi, prezzi stracciati prezzi rovinati, dura la vita per un prezzo, prezzi a ribasso prezzi all’ingrosso, un buon prezzo si deve tagliare, si deve tagliare, dividere, umiliare, trenta cinquanta settanta percento. Paghi tre prendi due, paghi sei prendi nove, nuovo!, il nuovo al prezzo dell’usato, e l’usato è sempre garantito. Il nuovo risparmio è spendere bene, spendere meno spendendo meglio, alla città della convenienza. I prezzi cattivi non sopravvivono, vengono licenziati, cancellati, mandati al macero. La notte i prezzi sognano di cadere in un grande ovale bianco, solidamente bordato di nero, e di precipitare in eterno, senza mai toccare il fondo.
Il quartiere dell’abbigliamento è illuminato a giorno da grandi falò allestiti su piedistalli d’argento e cristallo, e alimentati perpetuamente con i capi delle stagione passate. Ora è di moda la tinta zigomo: le vetrine traboccano di calzini zigomo, cappelli zigomo, giacche zigomo, mutandoni di lama zigomo, guanti zigomo, cappotti zigolo, stringhe zigomo per scarpe zigomo, cinture zigomo su jeans amaranto. L’amaranto si abbina molto allo zigomo. La scorsa stagione andava un altro colore, il lucciola. Ha sbancato, ma poi è stato deprezzato, ribassato, strascontato. I fondi di magazzino sono giù stati inceneriti. Ora i capi color lucciola sono rarissimi; se ne vende qualcuno nei negozi di abbigliamento vintage, ma i prezzi sono proibitivi. Per la stagione a venire non si esclude un ritorno di fiamma del lucciola.
Il cuore del quartiere della moda ospita tutte le grandi firme. La concorrenza è spietata, non solo tra uno stilista e l’altro, ma tra uno stilista e i suoi imitatori. Il famoso designer Buzzini ha aperto una fabbrica in Cina per produrre i falsi della propria collezione. Ora le imitazioni autentiche di Buzzini spopolano nella città della convenienza. «Questo dimostra che posso creare imitazioni di Buzzini meglio di chiunque altro», ha commentato lo stilista.
Il quartiere degli spettacoli è scintillante. La strada è costellata di Elvis morti e di bambole gonfiabili di Marilyn. I cinema proiettano tre film al prezzo di uno, e sono sempre film a colori, consunti, col finale che fa piangere di gioia. Cabarettisti sdentati e flaccida prime donne si ammassano sui palcoscenici di varietà. Attori comici rovinati da scandali sessuali, rockstar ultrasessantenni, maghi televisivi caduti in disgrazia siedono per strada, dentro cabine di vetro attrezzate con un cesso e un piccolo frigorifero. Il prezzo per gli autografi sta scritto su un cartello di cartone che tengono appeso al collo. Alcuni si fanno fotografare in cambio di un bicchiere.
Modelle ingrassate e soubrette dai culi cascanti cantano in playback in orchestrine da ristorante, si travestono da scoiattoli giganti, o imparano a sputare fuoco. I marciapiedi davanti alle sale cinematografiche pullulano di petomani e di clowns. Guidano velocipedi senza manubrio e con una ruota sola. Hanno scoperto di riscuotere più monete e risate quando rovinano a terra, purché il costume sia abbastanza colorato da distrarre il pubblico dal sangue lasciato sull’asfalto.
I clienti si affastellano per le strade strabuzzando gli occhi, sudando e sorridono compulsivamente, le braccia distese lungo i fianchi, borse cariche di merce in ciascuna mano. Fiumi di passanti ingombrano le strade fino all’intollerabile. I bambini gridano a squarciagola oppure sghignazzano battendo i denti fino a farseli saltare fuori dalla bocca. I genitori hanno scoperto che tacciono quando li fanno ingozzare di hamburger.
Gli abitanti della città della convenienza soffrono di disturbi della personalità non diagnosticati, ma nessuno ci fa caso. Di giorno lavorano come grossisti, commessi o caporeparto. Sono pagati a giornata. Alla sera si riversano per le strade del quartiere a luci rosse. Impilano cassette di frutta l’una sull’altra fino a ottenere squallidi palchetti, sui quali imbandiscono aste improvvisate. Vendono la moglie, la madre e la sorella. L’asta è frenetica: non appena il banditore si è sbarazzato della merce, corre a un’altra asta, sventolando i soldi appena guadagnati, e urla il suo rilancio fino a comprare la moglie, la madre o la sorella di un altro banditore. Il denaro e le donne passano furiosamente di mano in mano, fino al mattino.
Chi non ha denaro né parenti di sesso femminile si dedica a commerci più miserevoli: lo zoppo compra l’occhio del muto, il cieco si svende i capelli. Le più efferate varianti della roulette russa si consumano nei vicoli più squallidi, nei salotti tappezzati di pelle, e su certi innominabili giardini pensili.
Sono sorti nuovi grattacieli e hotel di lusso, alla città della convenienza. Il comune sostiene che la grande macina di carne umana è in costruzione, promette che entrerà in funzione quanto prima. Ma l’ubicazione del cantiere è segreta, e alcuni hanno iniziato a sospettare: forse la macina è sotterranea, oppure invisibile. Forse si trova nell’aria tutt’intorno alla città, ed è già in funzione da molti anni.
mercoledì 30 settembre 2009
Making Movies su Delirio.net
Hector Luis Belial parla di Making Movies nella rassegna letteraria di settembre di Delirio.net. Un grazie a Eliselle.
venerdì 25 settembre 2009
Racconti: La Camera degli Echi
[Pdf]
Nella camera degli echi, un bisbiglio diventa un urlo, una piuma pesa quanto un macigno, una scintilla provoca istantaneamente un incendio. La leggenda è tanto nota quanto corrotta, dopo secoli di trasposizioni capziose, deliberatamente incorrette, o voluttuosamente fantasiose. Tutt’oggi manchiamo di una bibliografia soddisfacente sull’argomento. Siamo ancora costretti a rifarci agli studi di Voitiov, già annosi, e per di più circoscritti alle versioni russe della narrazioni, ma quantomeno puntuali nel riconoscere le due vulgate principali.
Nella prima versione, la più ovvia, la camera amplifica ciò vi si diffonde all’interno. Le pareti non si limitano a rimandare il suono, ma ingigantiscono il peso, la temperatura, il colore, il sapore, e qualsiasi altra proprietà fisica degli oggetti che vi sono posti. Basta immettere un fiocco di neve, e la camera si fa gelida; un soffio di fiato genera un ciclone, ed è meglio prestare attenzione all’acqua: una sola goccia, cadendo sul pavimento, provoca l’allagamento del locale. La camera non aumenta però la quantità degli oggetti: è celebre l’episodio del servo che tenta, all’insaputa del Re, di decuplicare una moneta d’oro ricevuta in dono. Non solo la camera non moltiplica la sua ricchezza del servo, ma rende la moneta accecante e tanto pesante che sette cavalli non riescono a smuoverla da terra.
Molte delle fiabe catalogate in questa categoria vogliono la camera altresì capace di accrescere le emozioni di chi vi si rinchiude. Queste storie giustificano l’edificazione della camera degli echi come raffinata sala di torture o di piaceri. Il prigioniero innamorato diventa ossesso, il melanconico depresso, il violento masochista e poi suicida. Chi non muore per l’esasperazione del proprio sentire esce dalla camera degli echi in preda a gravi squilibri mentali. Non mancano però storielle erotiche – ed esotiche, spesso, ambientate in Arabia o nell’estremo Oriente – nelle quali la camera è teatro di banchetti e celebrazioni orgiastiche, durante le quali i piaceri della gola, dell’ebbrezza del corpo sono portati al parossismo. Molte tra queste ultime narrazioni hanno sapore rabelaisiano e comico, ma non mancano i finali moralistici (con l’inevitabile comparsa del demonio) e le autentiche tragedie, nelle quali l’orgia nella camera degli echi è la decadente e disperata conclusione di un lungo assedio, e un preludio all’inevitabile morte.
La seconda vulgata include le storie che vogliono la camera degli echi come una sorta di cabina di ascolto, nella quale le pareti ripetono alle orecchie del Re quanto si dice in ogni angolo del regno. In queste storie la camera è spesso il dono di un demone, di uno stregone, di un malvagio consigliere o di un sinistro alleato. È facile riscontrate una struttura comune alle fiabe del secondo tipo: il Re dapprima utilizza la camera in maniera fruttuosa, smascherando complotti a suo danno, infedeltà coniugali o avanzate di eserciti nemici grazie alle proprietà magiche delle pareti. Ma in seguito, la camera diventa dannosa: le voci che ripete giungono irrimediabilmente deformate. Ascoltandole, il Re manda a morte un innocente, muove guerra ad un regno amico, ripudia una moglie fedele. Il finale include in genere – ma non sempre – il riconoscimento da parte del Re del proprio errore, la demolizione della camera degli echi e la punizione del suo costruttore.
La descrizione della camera è quasi sempre insoddisfacente. Ne ignoriamo sempre le dimensioni, e in molti casi, anche l’ubicazione. In alcune storie la camera è ricavata in una caverna nel cuore di una montagna, in altre, costruita in una segreta sotto le fondamenta del palazzo. Non mancano camere degli echi sfarzose e riccamente arredate, ma siamo più spesso portati ad immaginarle completamente spoglia. In una celebre versione del XVII secolo, la camera degli echi è rivestita di specchi d’argento, appartiene alla Regina di Saba, ed è nota come “camera delle vanità”.
La camera degli echi moderna sarà realizzata con l’applicazione delle più moderne tecnologie. Ancora non sappiamo se somiglierà più alle camere descritte nella prima o nella seconda vulgata: è probabile che potremo passare da una funzione all’altra tramite un pratico telecomando. Le prime camere degli echi funzionanti saranno installate in alberghi di lusso e parchi di divertimento, ma non si escludono versioni per l’uso domestico. Anzi, già si pensa alla miniaturizzazione, con versioni da salotto e addirittura tascabili. La camera degli echi del ventunesimo secolo, di fatti, sarà minuscola e prodotta in decine di milioni di esemplari, oppure unica, gigantesca, e in grado, grazie all’ausilio di una rete di satelliti, di inglobare l’intero pianeta.
venerdì 18 settembre 2009
Cinéma Belial: Mary and Max
Mary and Max (Australia 2009), scritto e diretto da Adam Elliot.
Il cinema d’animazione per adulti (leggasi: non strettamente per bambini) ha un pubblico? I distributori italiani sembrano dubitarne. Eppure, se ieri sera uno solo di questi signori – che immagino troppo impegnati per vedere tutti i film ai quali negano la diffusione – avesse messo piedi nella sala grande del teatro Dal Verme (1400 posti), si sarebbe dovuto accontentare di un posto a sedere sui gradini. È la prima volta in quattordici anni che gli organizzatori del Milano Film Festival ammettono al concorso per lungometraggi un film d’animazione. Trattasi di Mary and Max, opera prima dell’australiano Adam Elliot, ignorato dalla distribuzione italiana e proiettato ieri in anteprima nazionale. La risposta del pubblico? Sala gremita, scrosci di applausi.
«Una bimba australiana a colori e un ebreo di New York in bianco e nero, diventano per caso due amici di penna surreali», ci informa il programma del MIFF. Il termine “surreali” è fuoriposto nella frase quanto la virgola, ma la sinossi è almeno efficace nel dare un’idea della semplicità del soggetto. Economico nella durata, nelle ambientazioni e nel numero di personaggi, Mary and Max riesce comunque ad essere spettacolare e spassoso grazie alla magistrale animazione in stop motion e a una sceneggiatura spregiudicata.
Elliot ha avuto il coraggio, ancora relativamente raro, di inserire in un film d’animazione rappresentazioni dell’alcolismo, della malattia mentale e del sesso – tutto questo senza aggiungere un grammo alla leggerezza del film, complice una raffica di gag visive e verbali. Ancora più azzardato, e splendidamente fortunato, è il deliberato abuso della voce narrante e delle voci fuoricampo dei due personaggi (attraverso l’escamotage dell’epistolario). Qualsiasi manuale di sceneggiatura consiglia, per evidenti ragioni, di moderare l’uso di queste tecniche narrative; Elliott le usa per tutti i novanta minuti, eppure il film non perde ritmo né humour nemmeno per un secondo.
Banale, ma comunque funzionale, la scelta delle musiche. Philip Seymour Hoffmann dà la voce a Max, Tony Collette a Mary.
È tutt’altro che improbabile, visti i film concorrenti, che la giuria del MIFF ratifichi l’entusiasmo degli spettatori. Si potrebbe malignare che, in un concorso di opere prime e seconde di carneadini internazionali, Elliot ha gioco facile. L’australiano ha già portato a casa un Oscar per l’animazione col corto Harvey Krumpet, e Mary and Max è stato il primo film d’animazione di sempre ad aprire un’edizione del Sundace. Ma al di là dei trascurabili esiti della competizione, questa prima proiezione di Mary and Max ha chiarito un dubbio: il pubblico c’è. E la distribuzione?
venerdì 4 settembre 2009
Racconti: Kontroll
Prosegue la belializzazione degli scritti del Malabaila - i testi saranno infine raccolti in appendice al Meridiano (volume secondo) che compila "romanzi e racconti" dell'autore torinese. Questa volta è il turno del romanzo "L'amore ci farà a pezzi", riscritto nel rispetto di quell'efferata tradizione postmoderna che consiste nel dar voce ai di personaggi marginalizzati nel testo originale, assumendone il punto di vista... [Pdf]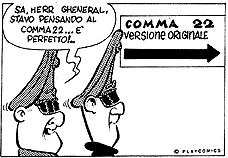
Puonciorno. Io zono Gunter Adolf Van Wolfensteinschloß, barone di Döppeldunkelbier. Io fiene fostro paese maccaroni Italia per fare Fendetta!
Io fiene e fa akkampamento in kampagna fuori città di Thorino. Io dorme in tenta prestata da Zio, tenta originale di ufficiale tetesco 1939, molto pella dekorazione di swastika sopra tenta di Zio. Qvuesta mattina Io prepara pikkola kolazione a pase di würstel cinkiale und scatola krauten bier, qvando un intigeno zi introduce in akkampamento. Supito itentifiko lui: fecchio fumatore di Pipa, nome Ricoperto Cammarino forse italiano terrone kollezionista und rifenditore di antikvariaten, oder ex fassista tratitore italiano spia. Esso osserfa mit ammirazione mein felifolo perzonale – fedele replika di aeroplano Messerschmitt Bf 109, io stesso coztruito con mie mani in età di funfzig jahre – und pella tenta di Zio, kompletamente reztaurato.
Io kontento lui ammira mio eqvipaggiamento, aber qvando lui difenta troppo kurioso, qvando lui guarda mia Makkinadimorte, allora Io punta lui in faccia mia Luger P08 di 1944 – semiautomatika und perfettamente funzionante. Esso tomanta ze Io kollezionista di ropa del Terzo Reich, ke kosa, urlo, Io sono Terzo Reich! A kvel punto fecchio fumatore italiano di Pipa fucce attraverso kampi cade in fango e urla mentre Io spara lui attosso und rito molto di lui. Poi Io mangia kolazione und intossa astuto trafestimento.
Ora Io foglio parlare di meine fidanzata und futura sposa Monika. Monika è Fräulein di non nopile famiglia aber pura razza ariana. Monika cioca Tennis. Monika è puona racazza, puona dice voi italianen qvando Fräulein ha große tette, ja? Monika molto puona racazza.
Però Monika non puona con Me, Monika mette me Korna. Und non dice korna piccole di kapretto, nein, grande Korna, grandissima Korna di Steinbak, di renna di Finlandia. Io non kapisce perché lei mette me Korna. Io è Übermansch. Io muskoli wunderbar, ja, Io spacca Montagna Incantata mit una sola Mann, Io intellighenzia superiore, Io Inceniere militare aeroautika, jawohl!, Io infinita ricchezza, infinito tanaro, capisce? Und Io grande motestia, anke.
Aber Monika mette me Korna. Qvando Monika gioca tennis in Italia, io rimane in kastello di famiglia in Döppeldunkelbier, aber sempre manda schpie perché segue Monika, Io sempre fuole Kontroll. Un ciorno Io è in torre ofest di Kastello, Io lafora a nufa makkina praezision, Makkinadiskuoiacinkiale, ja? Poi giofane paggetto Filipp pussa a mia porta und dice Monika mette me Korna, dice Monika mette te korna con manciaspachetti! Io allora fa Sturm und Drang, io prente giofane paggetto Filipp per piondi capelli und scarafenta lui giù di torre ofest di Kastello. Io decide buttare anke Monika giù di torre ofest, aber Nonno Sigrifido dice no Gunter Adolf, tu non ti arrappia kon tonna, dice Nonno Sigfrido, è normale che tonna mette te korna, spieca Nonno Sigfrido, tutte tonne è skvaltrine!
Io zupito kapisce grande racione Nonno Sigfrido, aber Io non fuole grosse Korna in testa, Io fuole Sturm und Drang fare und supito. Allora Nonno Sigfrido da me lipro, non lipro Tetesco, amerikanolipro! Io domanda a Nonno perché lui dà me lipro di nazione perfertita und piena di kospirazione epraica, in amerika ogni tonna è prostituta und ogni uomo pederasten, ma Nonno ortina lecci qvesto lipro Der scharlachrote Buchstabe.
Io allora lecce storia di doktor Chillingworth. Doktor Chillingworh apita in prutto regno di Pretagna, aber possiede moglie in amerika. E kvando doktor Chillingworth va amerika, trofa moglie ha messo lui grandi, grandissime Korna di toro kastrato. Ora Moglie ha Figliadialtrouomo aber nessuno sa ki. Per fortuna doktor Chillingworth grande intellighenzia, lui supito scopre ke amante sua Moglie è in realtà Prete. Allora cosa fa doktor Chillingworth? Fa lui Sturm und Drang? NEIN! Doktor Chillinworth grande pazienza. Lui difenta amiko und mediko di Prete, lui ciorno dopo ciorno affelena Prete. Doktor Chillingworth è qvasi meglio di doktor Faustus, und dopo qvalke anno di feleno Prete finalmente muore.
Io kapisce grande insegnamento di lipro amerikano und non lafora più Makkinadiskuoiakinchiale. Io fa altra makkina più perfetta, makkina di astuta Fendetta, Makkinadimorte. Intanto schpie da me tutta informazionen su mio affersario. Esso non è Prete, esso finge se stesso Giocatore Tennis und Schrittore, aber è soltanto vile doncifanni italiano latino, uomo chiamato con nome di tonna Andrea. Spie dice me ke lui mai askolta musika di uomo (Wagner oder Rammstein), no, lui askolta decenerati Öasis di regno pritannico. Schpie dà me foto di lui a concerto di Gut Charlotte, lui paca piglietto di Gut Charlotte, lui mostra se stesso senza fergogna in pubblico di Gut Charlotte! Das ist inaccettabile!!! Io guarda sua foto: esso tince suoi capelli biondo und kolora sua faccia pianco, aber io fede chiaramente segni di giudaismo mescolato kon negro und russo sangve stalinista. Io sorprende Monika non capisce lui finto ariano!
Dunqve io lafora ciorno und notte a Makkinadimorte, e qvanto fede lei funziona molto pene, supito karika lei su mio Messerschmitt replika und schnell fola a fostro paese Italia – dofe Europa inizia somigliare Afrika. Io installa ratiotelefono di kampo, autentiko di 1942, und telefona Andrea. Lui rizponde Pronto, io dice Puociorno. Io allora dice lui mio fintonome, Johan Schmidt, Io dice lui Io sono rappresentante di Spielberg GmbH, grande ditta tetesca di Makkinedisportprofessionalen. Io presenta lui nuofo prodotto, makkina di allenamento tennis, nuofa Makkinasparapallinen. Io dice Spielberg Gmbh fuole lui per testimonial pupplicità italiana Makkinasparapallinen; Io dice se tu fiene domani in Kampotennis Thorino ore Qvindici noi fotografa te poco e paca te molto Euro. Und Andrea cade in astuta trappola, natürlich.
Kosì io va in Kampotennis Thorino ore Qvattordici und installa Makkinasparapallinen und Fotokamera. In qvesto moto, kvando Andrea arrifa, lui penza che makkina spara pallinen e lui colpisce pallinen con rakketta, come normale allenamento Tennis. Aber qvesto non è normale allemento tennis und Makkinasparapallinen è in realtà Makkinadimorte apilmente kamuffata! Io tolto pikkolo motore di Makkinasparapallinen elettriko und messo grosso tetesco Motore Porsche potenza 3000 penzina. Kosì kvando Makkina spara pallina (io ha riempito molta pallinen mit piombo fuzo) Andrea non ripatte palla con rakketta, no! Palla puca rakketta! Palla puca praccio di Andrea! Palla puca suo petto, und fa esplotere sua testa, und pezzi di cerfella fola per tutto Kampotennis Thorino. Intanto io fotografa sua sangvinosa morte und rite. Prima ke arrifa maccarone di Polizei italiana io già fola su mio molto pello Messerschmitt replika sopra Alpen, e kvando io atterra in Döppeldunkelbier fa grande panketto Birra salsiccia puttane.
Qvesto è il piano. Aber ad ore Qvindici und dieci minuten Andrea ancora non è in Kampotennis Thorino. Lui arrifa mit venti minuten Ritarto und non fiene solo, Monika fiene con lui! Io li fedo si afficinano un lui pacia Monika lui mette mano sopra suo kulo. Inaccettapile! Io fa subito Sturm und Drang. Io non aspetta ke lui entra in kampo, supito accende Makkinasparapallinen und palline pukano la rete und fanno crollare Torredilegnodiarpitro, und fa esplotere automobile Andrea (Makkina con nome di tonna) und distrucce fetrina di par. Aber io non riesce a kolpire lui, Monika urla mio nome und skappa und anche Andrea corre fia, figliacco gli urlo ma non serfe a niente. Makkinsparapallinen continua distruccere tutto, kase iniziano a prendere fuoco e crollare (gittata di pallinen è tre kilometri), gente urla e si putta da finestre.
All’improffiso, da fumo di macerie esce mostro di acciaio. Io non crede miei okki: esso è originale sofietico OT-130 panzer leggero mit lanciafiammen, panzer di seconta Gverra kompletamente restaurato. Makkinasparapallinen non può fermare esso, OT-130 sofietico komunista si afficina, ferma kon lanciafiamme puntato su me. Si apre potola, esce pikkolo uomo. Io fede lui è Ricoperto Cammarino fecchio fumatore di pipa di qvesta mattina italiano. Lui parla in megafono americano oricinale 1945, lui dice tu non muofere, tu cirkondato, tu arrente in nome di Associazione Nazionale Di Italia Kollezionisti Antikvariato Pellico. Alle mie spalle io sente chiaramente afficinarsi italiano panzer pesante P40 di 1941, mezzo anfibio pritannico LVT di 1944, und sopra mia testa fola tetesco elikoptero Flettner FI282 Kolibri 1943. Tutti kvesti mezzi è perfettamente funzionante kome nuofo und reztauraten. Io kapisce Io kaputt.
Arrenderzi?, dice Io, ciammai! Heil Hitler! Fatefi sotto! Ciorno ke io mi fa uccitere di panda fecchi italiani collezionisti di pipa forrà dire ke Germ
martedì 1 settembre 2009
Biografie Potenziali: L'Appestato
Hector L. Belial è recentemente scomparso, vittima - secondo i medici - della Nuova Influenza. L'autore, che vantava dubitabili origini uzbeke, sarebbe stato contagiato all'ospedale San Pancrazio di Buduar, dove si trovava ricoverato in seguito ad un grave incidente d'auto.
-Il Belial-, racconta di dr. Prurito, laureato per corrispondenza all'università di Livorno, -di ritorno da una serata di sensibilizzazione contro la vendita dell'alcol ai minorenni, si era messo alla guida della propria autovettura nel più adeguato stato d'ebbrezza. La rovinosa uscita di strada nei pressi di un burrone gli ha provocato lesioni gravi alla spina dorsale, fratture multiple ad entrambe le braccia, l'amputazione della gamba sinistra, ustioni di terzo grado su metà del corpo, difficoltà respiratorie, danni permanenti all'udito e alla vista, nonché la rottura dell'unghia dell'alluce destro.-. La causa del decesso, tuttavia, non sarebbe imputabile ai postumi dell'incidente. -Il paziente-, conferma Prurito, -si trovava ormai fuori pericolo, in chiara via di guarigione.-. I sintomi dell'influenza A erano evidenti: -Era presente la mia equipe al completo, loro glielo confermeranno. Prima di registrare l'arresto cardiaco, l'abbiamo sentito starnutire.-.
Un altro decesso illustre ascrivibile alla Nuova Influenza, dunque, che va ad aggiungersi a quello del beneamato José "Cabron" Jimenez, beneamato produttore di sigari e comico del cinema muto passato a miglior vita la settimana scorsa. Jimenez, ecuadoregno, centododici anni e due polmoni artificiali, rientra negli annali della medicina moderna tra le vittime di complicazioni respiratorie dovute all'influenza A. Anche Fernanda Pivano, le cui esequie si sono svolte recentemente, non è stata colpita dal terribile virus. Frattanto, i 22 Boy Scout di Novi Ligure contagiati durante una vacanza-trasformata-in-tragedia in Galles, non sono stati decimati dalla Nuova Influenza.
Durante la sua ultima intervista, apparsa il mese scorso sulla rivista britannica Mojo, Belial aveva dichiarato: -Non ho la minima intenzione di vaccinarmi contro questa scemenza suina, o neoinfluenza o raffreddore A, come diavolo la vogliate chiamare. Sono nato a un anno dal disastro di Chernobyl, senza che le radiazioni mi provocassero nessun esubero nel numero di gambe e braccia. Ho commesso la follia di mangiare carne bovina - e più di una volta! - durante gli anni della mucca pazza, e sono miracolosamente sopravvissuto. E' clamoroso: non sono stato attaccato dall'aviaria, nessuno ha tentato di avvelenarmi con l'antrace, e, come se non bastasse, sono riuscito a non contrarre la SARS. Devo avere almeno un santo in paradiso, perché la terrificante epidemia di meningite, che ha distrutto un'intera generazione, mietendo milioni di miei coetanei, non mi ha nemmeno sfiorato. Sono sopravvissuto a tutto, sopravviverò anche a questo.-.
-La medicina ci insegna da sempre ad avere fede e a non sfidare la sorte.-, conclude con amarezza accademica il dr. Prurito.
martedì 11 agosto 2009
Cinéma Belial: Man on Wire (Marsh 2008)
Man on Wire (UK 2008) di James Marsh, con Philippe Petit.
Man on Wire è il documentario più premiato e meglio recensito dello scorso anno. È stato proiettato allo scorso Festival di Roma, ma non ha ancora ricevuto una distribuzione regolare in Italia.
È ormai ridondante lodare la qualità della realizzazione. James Marsh ha scelto un tipo di narrazione che ricorda i classici film caper, inserendo perfino qualche tocco espressionistico. Le “ricostruzioni drammatiche” sono talmente curate da affiancare le immagini di repertorio con una totale naturalezza. Il montaggio è incalzante, le musiche di Nyman (molte riprese dai film di Greenaway) azzeccate. Ma naturalmente, tutto questo passerebbe in secondo piano se non fosse per il fascino del soggetto.
Il mattino del sette agosto 1974, dopo anni di preparativi, il funambolo francese Philippe Petit portava a compimento la sua impresa più estrema: si esibiva a 417 metri dal suolo, sopra un cavo d’acciaio teso tra le due torri gemelli del World Trade Center di New York. Senza cavi di sicurezza, senza protezioni, e naturalmente, senza alcuna autorizzazione.
La performance di Petit è considerata da alcuni come una provocazione al simbolo del capitalismo; interpretazione riduttiva. La provocazione di Petit ha uno spettro molto più ampio: rovescia le paure ataviche dell’uomo, e sfida le leggi della fisica molto prima di irridere i poliziotti che vengono ad arrestarlo sul tetto del WTC. Anche le convenzioni dello spettacolo risultano sovvertite: certo, l’impresa regalerà a Petit una grande fama. Ma in un’epoca in cui il quarto d’ora di successo è garantito a chiunque, un uomo non ha bisogno di rischiare la vita in maniera così deliberatamente elaborata per ottenere il suo momento di gloria. È evidente che Petit è mosso da uno spirito più selvaggio, determinato, e fondamentalmente irrazionale, mentre si lancia verso la sua herzogiana “conquista dell’inutile”.
Per le riprese di Fitzcarraldo, Herzog volle portare una vera nave su una montagna nel bel mezzo della giungla, rifiutando i trucchi cinematografici che gli avrebbero di gran lunga semplificato il compito, a costo della personale bancarotta. La performance di Petit è di natura simile: titanica, spettacolare, splendidamente inutile ed in qualche modo commovente. L’impresa di Petit sempre però in qualche modo più perfetta, forse perché sembra coinvolgere più direttamente un singolo individuo e richiedere mezzi più esigui. In realtà Petit non avrebbe potuto realizzare la performance senza l’aiuto di un’equipe e di due tonnellate di attrezzature; tuttavia, una volta fissati i cavi, il funambolo è solo sopra il baratro, solo davanti alla morte.
«If i die… what a beautiful death, to die in the middle of this exercise!»
In Petit, dunque, il desiderio di autodistruzione è tanto forte quanto quello di auto perfezionamento. Si tratta, necessariamente, di spinte che riescono a bilanciarsi perfettamente, ma che nondimeno tradiscono la profonda irrazionalità del gesto. Quel che commuove non è il tentativo di un uomo di superare i propri limiti, le proprie paure. Sì, l’esercizio richiede la perfezione tecnica, una preparazione fisica e psicologica estenuante. Eppure non siamo di fronte ad una prova agonistica sportiva, né ad un cammino di elevazione spirituale. Quando guardiamo Petit camminare sopra New York, stiamo assistendo ad un’opera d’arte perfetta, il frutto di una dedizione totale, estrema, parossistica.
Fino a un certo punto del film, Petit sembra l’incarnazione del trapezista kafkiano. In seguito, diventa semplicemente una star. Dopo essersi arreso alla polizia, il funambolo viene trascinato in un istituto psichiatrico. E forse sarebbe questo l’epilogo più calzante alla sua storia: la bellezza del suo gesto incompresa, condannata, in una caduta più profonda della morte. Ma naturalmente Petit viene liberato, applaudito dalla folla, scagionato da tutte le accuse, perfino premiato con un ingresso libero a vita per l’osservatorio del WTC. E, come sappiamo, gireranno un film su di lui, un film molto bello, fra l’altro. Mi chiedo fino a che punto questo lieto fine sia tollerabile.
lunedì 27 luglio 2009
Making Movies: Una Recensione

Ringraziamo Izzy Fortune, che sul suo blog ha recensito Making Movies. Potete leggere la recensione qui.
lunedì 29 giugno 2009
Cinéma Belial: Un Amor de Borges (Torre 2000)
Un Amor de Borges (Argentina 2000, 93') di Javier Torre, scritto da Isabel de Estrada e Javier Torre, con Jean Pierre Noher e Inés Sastre.
Buenos Aires 1943. Il bibliotecario Jorge Luis Borges, ancora lontano dal successo letterario e già vittima dei primi sintomi della cecità, si innamora della giovane Estela Canto, attrice radiofonica, traduttrice di polizieschi e comunista militante. Ma, succube della madre possessiva e di un’opprimente timidezza, Borges si orienta a fatica al di fuori del mondo della letteratura.
Tratto dal memoriale "Borges a contraluz" di Estela Canto, Un amor de Borges è un melodramma che riesce nell’intrecciare la storia romantica con il sottotono politico e letterario. Il clima opprimente dell’argentina peronista è reso con efficacia, mentre la genesi dello straordinario racconto El Aleph (Borges lo dedicò alla Canto) fa da contrappunto all’intera vicenda.
Il film naturalmente trova il suo interesse principalmente nella rappresentazione del poeta di Buenos Aires, che funziona grazie all’ottima prova di Jean Pierre Noher. Il narratore sempre così glacialmente distante dalle sue creazioni si incarna qui in un essere penosamente umano, goffo nel camminare e nel baciare, non riesce a fare a meno di balbettare, di ripetere all’infinito i suoi “disculpame”, di abbandonare la tavola di una cena romantica per telefonare alla madre. Un completo inetto che però, quando si sdraia sul pavimento della cantina che servirà da ambientazione al racconto, e fissa il diciannovesimo scalino, è in grado di immaginare
“il popoloso mare, l’alba e la sera, le moltitudini d’America, un’argentea ragnatela al centro d’una nera piramide, un labirinto spezzato (che è la città di Londra), infiniti occhi vicini che si fissano in me come in uno specchio, tutti gli specchi del pianeta, un cortile, grappoli, neve, tabacco, vene di metallo, vapor d’acqua, convessi deserti equatoriali e ciascuno dei loro granelli d’acqua […]”.
Sembra allora davvero che l’Aleph, una sfera di pochi centimetri di diametro in grado di contenere l’intero universo, sia veramente lì, a portata di mano. Se possiamo credere in uomo di quarant’anni che non ha mai imparato ad allacciarsi le scarpe da solo, e che eppure riesce a scrivere pagine inarrivabili, avremo in qualche modo affermato il segreto di Borges, un essere impossibile, fantastico, paradossale e piacevolmente contraddittorio, esattamente come i suoi racconti migliori.
Nonostante la bravura degli attori, professionalità del regista, ed una sceneggiatura abilmente disseminata di riferimenti all’opera borgesiana, traspare una certa povertà di mezzi che troppo spesso ricorda una convenzionale produzione televisiva. Dannosa la colonna sonora originale, non di rado stucchevole. Resta una visione piacevole, almeno per gli amanti dell’opera del maestro argentino.
giovedì 25 giugno 2009
Centogradi: un nuovo racconto su WebSite Horror

Su WebSite Horror - il sito di Marco Candida recentemente segnalato su Nazione Indiana - è apparso un nuovo racconto di Hector Luis Belial. Potete leggerlo qui.
martedì 2 giugno 2009
Cinéma Belial: Youth Without Youth (Un'altra giovinezza, Coppola 2007)
Nasce la rubrica Cinéma Belial: opinioni non richieste su film non troppo visti. In questo numero: il curioso caso di Francis Coppola, le regole della casa del sanscrito, e tutto il fascino dell’India in biplano… 
Fulmini. Persone colpite da fulmini. Prima un uomo, poi una donna. Un vecchio linguista e una giovane proto-hippie, per la precisione. Nessuno dei due muore. Il primo ringiovanisce, diventa intelligentissimo e ricercato dalle SS. La seconda si mette a parlare in sancrito, in egiziano antico, in babilonese… Ah, oltre a ringiovanire, il linguista si sdoppia; ha un doppelgänger cattivo che gli parla dagli specchi.
Il soggetto di Youth Without Youth (Un’altra giovinezza, 2007), è ridicolo, e allo stesso tempo affascinante. Portare sullo schermo una storia del genere dà luogo ad almeno due certezze: il fallimento al botteghino ed il biasimo di una parte della critica, nella fattispecie quella americana. Ma c’è chi se lo può permettere: Francis Ford Coppola, che ha scelto di tornare alla regia dopo dieci anni con un film estremamente europeo, piuttosto classico, ed altrettanto anomalo. A noi è piaciuto.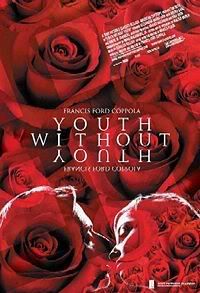
Girato in digitale in un'ottantina di giorni, con Tim Roth come unica star, Youth Without Youth deve buona parte del suo interesse e la quasi totalità dei suoi difetti alla sceneggiatura. L’ha firmata lo stesso Coppola, ed è un adattamento dell’omonimo romanzo (ristampato per l’occasione da Rizzoli) di Mircea Eliade, poliglotta e storico delle religioni rumeno. La trama presenta una sua precisa simmetria, ed un’originale mescolanza di fantastico borgesiano, fantascienza wellsiana, avventura stevensoniana, non senza tocchi di metafisica. Eliade si spinge anche a toccare tematiche non banali, come la seconda giovinezza e la glossolalia. Il tema del doppio, invece, appare un po’ banalizzato, forse addirittura superfluo nell’economia della storia.
Dominic Matei, un linguista e poliglotto romeno ultrasettantenne (Roth), disperato dall’incombenza della morte e dall’impossibilità di completare il lavoro della sua vita – un saggio sull’origine del linguaggio e della coscienza – si reca a Bucarest per suicidarsi. Ed è qui che viene colpito dal fulmine; la scena in cui Roth viene sollevato da terra, elettrizzato ed infine abbandonato sull’asfalto è peraltro la più inguardabile dell’intera pellicola, ed ha l’unica qualità di finire presto. L’idiosincrasia di Coppola per gli effetti speciali digitali è nota, ma non costituisce un alibi per una scena indegna di un horror di serie b degli anni ‘20. Tornando a Matei, immediatamente ricoverato in ospedale, durante la sua convalescenza non solo si riprende completamente, ma si ritrova più giovane di almeno vent’anni, nonché dotato di una memoria e di risorse mentali pressoché illimitate. Userà questi doni per continuare la sua opera, che tuttavia non potrà essere completa fino a che, molti anni dopo, in Svizzera, non incontrerà una ragazza (Lara) che, dopo lo shock per la caduta di un altro fulmine, parla esclusivamente in sanscrito…
Il tema del ringiovanimento rende inevitabile il confronto con The Curious Case of Benjamin Button (Il curioso caso di Benjamin Button, 2008). In entrambi i casi, l’inversione della naturale tendenza all’invecchiamento viene dispensata da un’entità superiore che rimane innominata. Nel film di Fincher possiamo supporre un benevolo disegno divino – le difficoltà dell’infanzia di Benjamin vengono compensate dalla ricchezza, dall’amore e dall’avventura; e non sottovalutiamo il fatto che questo vecchio raggrinzito, ringiovanendo, diventa Brad Pitt… Il film di Coppola è molto meno consolatorio. Certo, grazie alla sua straordinaria intelligenza, Dominic può vivere tranquillamente coi soldi sistematicamente al casinò; né gli è risparmiata la storia d’amore della sua vita e qualche scampagnata esotica (l’India, anche qui). Ma la sua “giovinezza senza giovinezza” è chiaramente di natura diabolica, faustiana. È vero, gli è stata concessa una seconda vita, ma solo affinché la sacrificasse per le sue ricerche; a quest’opera, che costituisce la sua speranza d’immortalità, dovrà immolare anche l’amata, consumata dall’attività mediatica.
A proposito di glossolalia (il fenomeno per cui il parlante giunge ad esprimersi in lingue inesistenti oppure a lui sconosciute), è probabile che Eliade abbia tratto ispirazione dal caso di Hélène Smith, ampiamente trattato dal linguista Roberto Giacomelli in un volumetto del 2006. La Smith, una giovane commessa nonché sensitiva legata all’ambiente della teosofia nella Ginevra di fine Ottocento, si esibiva infatti mentre, in stato di trance, si esprimeva in sanscrito, sostenendo essere la reincarnazione della principessa indiana del XV secolo Simandini. Lo studio di Giacomelli, naturalmente, sfata i risvolti esoterici della vicenda, ma la somiglianza con la storia di Eliade rimane evidente. È d’altronde probabile che Eliade fosse venuto a conoscenza del caso della Smith dagli studi di Flournoy e Saussure.
Purtroppo il film di Coppola fallisce nel mantenere intatta la sospensione dell’incredulità per le oltre due ore della sua durata. Paradossalmente, e nonostante una storia non meno improbabile, Benjamin Button regge molto meglio sotto quest’aspetto; sarà che l’aura da kolossal hollywoodiano predispone meglio lo spettatore all’improbabile e al meraviglioso. Resta il fatto che il Padrino è tornato, e con un film originale, per molti aspetti raffinato, non senza pecche e non per tutti i palati, ma in fondo è meglio così. Per chi, come noi, l’aveva perso, vale la pena di recuperarlo; aspettando Tetro…
Bibliografia
Giacomelli, Roberto: “Lo strano caso della signora Hélène Smith”, Scheiwiller, Milano 2006.
Eliade, Mircea: “Un’altra giovinezza”, Rizzoli, Milano 2007.
lunedì 1 giugno 2009
Marco Montanaro Intervista Belial

Su il malesangue, blog di interviste fittizie e reali, potete leggere un'intervista di Marco Montanaro ad Hector Luis Belial a proposito di Saxophone Street Blues. La trovate qui. Un grazie a Marco Montanaro, già vincitore del primo Premio Belial.
Pubblicato da
Hector Luis Belial
alle
14:23
0
commenti
![]()
Etichette: Interviste, Saxophone Street Blues
martedì 19 maggio 2009
Una canzone ispirata a Babel
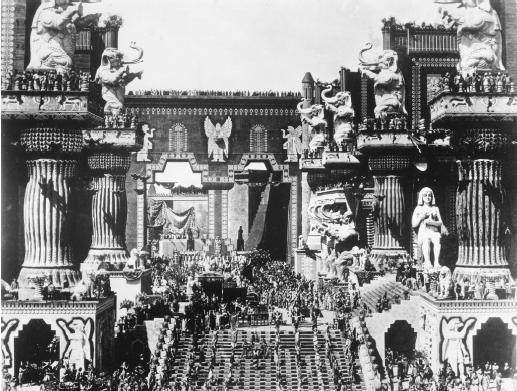
La cantautrice Paola Franzini ha composto una canzone ispirata al racconto Babel di Hector Luis Belial. Potete ascoltarla qui.
giovedì 14 maggio 2009
Alla Fiera Internazionale del Libro di Torino

Las Vegas Edizioni: Padiglione 1, Stand D87
Domenica 17, alle 15, tavola rotonda al Sesto Padiglione nell'area pedonale Grattacielo Lancia di via Caraglio angolo via Lancia: Andrea Malabaila presenta L'amore ci farà a pezzi (Azimut), Hector Luis Belial presenta Making Movies, Beppe Marchetti presenta Un'altra estate, Alessandro Bastasi presenta La fossa comune (Zerounoundici).
domenica 3 maggio 2009
Cinéma Belial: Synecdoche, New York (Charlie Kaufman 2008)

Un anno fa Charlie Kaufman, già sceneggiatore di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Essere John Malkovich ed Il ladro di orchidee, presentava a Cannes il suo esordio alla regia. Il film ha un titolo – Synecdoche, New York – ma non ancora una data d’uscita in Italia. Il che, naturalmente, non ci ha dissuaso dal vederlo…
Una sinossi del film, a questo punto, si rivelerebbe utile; ma la nota complessità delle sceneggiature di Kaufman le rende assolutamente allergiche alla sintesi, e Synecdoche, New York non fa eccezione. Il confronto col video Bachelorette, diretto da Michel Gondry, sorge spontaneo, se non altro per una facile associazione di idee. Synecdoche, New York propone lo stesso straniante meccanismo di mise-en-abyme in cui uno spettacolo teatrale riproduce infinite volte il reale – e quindi se stesso. Al posto di Bjork, però, troviamo un Philip Seymour Hoffman all’apice del nerdismo e dell’ipocondria.
Hoffman veste i panni di Caden, regista di teatro frustato ed ambizioso; «a man already dead».
La sua vita va esattamente per il verso giusto: i medici gli diagnosticano malattie oscure, la moglie fugge in Germania con la figlia, la relazione extraconiugale con Hazel è quantomeno insoddisfacente. Il teatro, invece, va a gonfie vele: la sua innovativa messa in scena di Morte di un commesso viaggiatore è un successo, tanto da valergli il premio MacArthur, che gli garantisce fondi illimitati per realizzare un nuovo progetto artistico. Deciso ad utilizzare il denaro per realizzare uno spettacolo di brutale onestà e realismo, acquista un gigantesco magazzino di Manhattan: diventerà il set per una riproduzione maniacale della sua vita – e di New York. Con l’aiuto di una gigantesca troupe, nel corso di decenni di lavoro, l’intera città viene fedelmente ricostruita dentro il capannone. Sammy, un feticista che ha seguito ogni istante della vita di Caden per vent’anni, viene ingaggiato per recitare la parte del regista. E mentre i rapporti di Caden con il tempo ed il mondo esterno vanno deteriorandosi, la finzione all’interno del capannone si fa sempre più vertiginosa, i piani del reale e del rappresentato s’ingarbugliano, la realtà inizia a collassare…
Accostato agli altri film scritti da Kaufman, Synecdoche, New York conferma tutta la forza, la coerenza e la compattezza di una visione autoriale che in qualche modo trascende il ruolo tradizionale dello sceneggiatore. Possiamo certamente parlare di film di Kaufman, e non più solo di film scritti da Kaufman, senza per questo sminuire il talento visionario di registi come Jonze e Gondry. Ancora meglio, siamo in grado di definire i tratti di un personaggio-Kaufman, declinato da attori anche diversissimi tra loro, ma che fa sempre capo ad un evidente paradigma – autobiografico, siamo portati a supporre. Al di là dell’autoritratto/autopsia che Kaufman attua instancabilmente su se stesso, con un’autocoscienza creativa senza precedenti, il personaggio-Kaufman si dimostra anche uno spietato, patetico tratteggio dell’artista contemporaneo (sia regista di teatro, autore televisivo, attore cinematografico, o pittore dell’infinitamente piccolo, come la moglie di Caden); ed in un certo qual modo, dell’uomo contemporaneo.
Il problema – almeno una parte di pubblico lo considererà tale – è che molti degli elementi topici del cinema Kaufmaniano (e del personaggio-Kaufman) sono deliberatamente disturbanti. Rabbia esistenziale, solitudine, paranoia, fobie sessuali, le molte ossessioni, non ultima quella della morte. La pillola è amara, e la sua regia non cerca in alcun modo di indorarla.
In effetti la differenza tra la regia di Kaufman e quella di Jonze e Gondry non è tanto qualitativa, né quantitativa in termini di invenzioni visuali. La scrittura di Kaufman è sempre stata prepotentemente straniante, ma la sua regia sembra votata ad evitare quegli elementi giocosi, quelle invenzioni brillanti che i due registi di videoclip riuscivano ad inserire nella piena della mise-en-scene. Scrittore amaro e regista spietato, Kaufman ci propone per la prima volta il suo genio senza filtri, ma anche senza brio. Le situazioni paradossali in cui Caden si trova coinvolto non sono prive di humour (nero, assai spesso), ma qui l'autore sceglie di sopprimerne accuratamente il lato fantozziano, accentuando, con l’alienazione del personaggio, quella dello spettatore.
Le invenzioni restano numerosissime: una casa perennemente in fiamme, in cui Hazel sceglie di morire più che di vivere; il gioco di opposizioni tra il gigantismo di Caden ed i microscopici dipinti della moglie; l’inquietante – ed oscuramente rassicurante – doppelganger di Sammy; uno Zeppelin che sonda i cieli notturni di Manhattan; le imprevedibili ellissi temporali che regalano alla narrazione un ritmo improbabile.
La pellicola, tuttavia, risulta inevitabilmente monocorde, ossessivamente tetra, e quindi fatalmente destinata a pochi. E questo a dispetto delle idee vulcaniche, della produzione impeccabile, della straordinaria recitazione dei protagonisti. Kaufman riesce a disporre la totalità di questi elementi lungo un vettore che punta allo straniamento, ad un malessere esistenziale che trova nell’arte, nella medicina e nel sesso dei palliativi del tutto insufficienti.
È tanto patetico quanto inevitabile constatare che Synecdoche, New York è uno dei migliori film del 2008.
I film di Charlie Kaufman:
- Essere John Malkovich (1999; diretto da Spike Jonze)
- Human Nature (2001; diretto da Michel Gondry)
- Il ladro di orchidee (2002; diretto da Spike Jonze)
- Confessioni di una mente pericolosa (2002; diretto da George Clooney)
- Eternal Sunshine of the Spotless Mind [oscenamente localizzato in Se mi lasci ti cancello](2004; diretto da Michel Gondry)
- Synecdoche, New York (2008; diretto da Charlie Kaufman)
domenica 26 aprile 2009
Racconti: Una Sera al Drive-in
Una divertita belializzazione dell'omonimo racconto di Andrea Malabaila. [Pdf]
El Niño aveva appena fatto saltare le cervella di Jason Smith ed attivato il detonatore che avrebbe inizializzato l’esplosione delle Manifatture Smith Ltd. quando mise piede nel California Snack Bar. Il killer professionista, unico cliente nel locale in chiusura, si presentò come Earl Grey, esattore fiscale. Ordinò una birra ghiacciata e quell’ultima fetta di crostata alle ciliegie che la cameriera, una rossa, avrebbe altrimenti dovuto buttare.
Joe Badalamenti aveva avuto un’autentica giornata di merda. Aveva guidato il camion per 400 fottute miglia, nella pioggia e nella polvere, chiuso in una motrice puzzolente tappezzata di pin-up ritagliate dai più sudici giornaletti d’America, eppure tenendo sotto gli occhi l’unica foto che presentasse una donna vestita, ovvero la sua ragazza, Stella Robertson. Gli mancava giusto un pugno di miglia per tornare a strizzare quella fichetta quando un lurido sbirro aveva partorito la pensata di fermarlo per eccesso di velocità. Porca troia! Badalamenti l’avrebbe preso a calci, lo stronzo, ristrutturandogli la testa col cric, e l’avrebbe fatto, perdio, se il poliziotto, vedendolo saltare giù dalla motrice, due metri di cristiano con un diavolo per capello ed una spranga d’acciaio deforme salda nella mano destra, non si fosse pisciato sotto, lasciando ripartire il camionista con un semplice ammonimento.
Stella Robertson aveva venticinque anni, un sottopagato lavoro al banco del California, ed un fidanzato che stava accumulando un notevole ritardo sull’orario fissato per l’appuntamento. Così, quando il cliente vestito da becchino si presentò con un nome britannico ed un biglietto da visita con simboli ministeriali, l’idea di vendicarsi di Joe le sembrò inevitabile quanto la morte e le tasse. Servì Grey con un sorriso che avrebbe soddisfatto le curiosità di un odontotecnico, e che non venne meno neanche quando notò la macchia di sangue sul suo colletto. Non le importò, a quel punto, della bugia di Grey a proposito di un incidente di rasatura, ma della sua mano, della rapidità e della forza con cui aveva afferrato quella di lei prima ancora che riuscisse a sfiorargli la camicia, senza lasciarla andare, nemmeno quando Joe entrò sbattendo la porta a vetri.
Mentre parcheggiava di fronte al California Snack Bar, mentre, attraverso la vetrina, gli toccò di vedere quella troia della sua donna fare la scema col primo stronzo che passava per una birra, Joe Badalamenti ricordò le parole che suo padre gli aveva ripetuto per anni, e forse per la prima volta riuscì ad afferrarne il significato profondo. «Quando vai con le donne, non dimenticare il bastone». La mano di Stella era ancora in quella dello stronzo in giacca e cravatta quando Joe tirò fuori il machete.
La nuova Buick Special quattro porte morì ancora tre volte prima che Rupert Blavatski riuscisse a parcheggiarla correttamente al drive in. Ricordò le parole che suo padre gli aveva ripetuto per tutto il giorno, prima di prestargli l’automobile fresca di concessionario: «Andare con una donna non è diverso dall’andare in macchina. Certo, se non riesci nemmeno a mettere in moto…». Il volante, ora, gli tremava sotto le mani, le lenti degli occhiali erano appannate di un sudore che il sontuoso impianto d’aria condizionata non riusciva a raffreddare. Tentò di calmarsi, ma mentre cercava di spegnere l’autoradio dalla quale Bill Haley continuava ad urlare il suo ingenuo rock ‘n’ roll gli partì un colpo di clacson che gli valse più di un’occhiata feroce dagli abitacoli vicini. Sullo schermo comparve il titolo del film: Donne-Gatto della Luna. Seduta al suo fianco, Susy Smith infilò gli occhiali 3D realizzando che il primo appuntamento con Rupert correva seriamente il rischio di essere anche l’ultimo.
Stella lanciò un grido mentre la lama di Joe calava su El Niño, ma il killer, rapido come l’inferno, riuscì a schivare il colpo, la lama penetrò nel legno del bancone, mentre El Niño castigava il camionista con un destro sulla mandibola e un calcio ben assestato in pieno stomaco; il povero diavolo non aveva ancora fatto in tempo a piegarsi in due per il dolore che già l’assassino aveva estratto la pistola puntandogliela dritta alle palle. «Ti do trenta secondi per portare il culo fuori dalla mia vista, amico». Joe ne impiegò ventisette, per far uscire la motrice dal parcheggio del California; per allora, la lingua di Stella Robertson stava già saldamente nella gola del killer.
Le lenti bicromatiche degli occhiali 3D rendevano Rupert sostanzialmente cieco, ma non occorreva guardare il film per capire che si trattava di una stronzata. Del resto Rupert comprendeva che non era un problema di diottrie o di quelle ridicole tute spaziali, il problema era il silenzio che lo divideva da Susy, Cristo santo, doveva pur dirle qualcosa, ma cosa? Il discorso sull’eccitante possibilità di colonizzare la luna non aveva riscosso l’interesse della ragazza, e del resto Rupert era arrivato a credere che a Susy non importasse poi molto della fantascienza; certo leggeva molto, ma che genere di libri? Magari aveva letto anche lei quel racconto di Checov in cui uno stalliere non riesce a confessare il suo amore alla ragazza, anzi lo dichiara ma in seguito non riesce ad agire oltre, beh forse non era veramente uno stalliere ma il succo era che a causa della sua timidezza i due vivevano vite separate ed insipide ed un bel giorno si ritrovavano vecchi ed incapaci di amarsi, e mio Dio! Che Susy avesse letto quel racconto o meno, non era certo il caso di parlargliene! Così Rupert attaccò un discorso paranoico sull’aria condizionata della Buick.
El Niño guidava una Porsche 356 American Roadster nera, e Stella non se lo fece ripetere due volte, prima di chiudere il locale e saltarci dentro. Fuggivano nell'ombra della sera d’estate, rinfrescata dai pini che scorrevano lungo la strada, entrambi immersi nei propri pensieri – lei cercava di ricordare la programmazione del drive in, lui di immaginare come si sarebbe sbarazzato della ragazza dopo averla portata a letto - così non si accorsero che Joe li aspettava al bivio, né che la motrice si era lanciata all’inseguimento della Porsche, guadagnando rapidamente terreno, nessuno dei due ci fece caso, fino a che Joe non li tamponò violentemente.
«Sai, Susy, questo sistema di aria condizionata che montano su tutte le Buick, è sviluppato separatamente dalla vettura, presso stabilimenti segreti nell’Oregon e brevettato in tutti i paesi del mondo. Ora, come mai tanta segretezza attorno a un sistema per rinfrescare l’aria? Supponiamo per un istante che non sia progettato esclusivamente per rendere la guida più confortevole. Immaginiamo le sue tubature interne, costantemente refrigerate, e sagomate in modo da costituire il perfetto habitat per una coltivazione artificiale di potenti bacilli portatori di una malattia mortale. I bacilli maturi sono espulsi automaticamente dal condizionatore, diffusi nell’abitacolo, inspirati dal conducente e dai passeggeri, cioè da noi, Susy, da me e da te. E provocano una forma incurabile di polmonite fulminante latente, che può ucciderci in un istante e del tutto casualmente tra dieci anni o diciassette secondi, così, senza che ci si possa fare assolutamente niente… se fosse così, Susy, se fossimo ormai condannati dal complotto farmaco-sovietico-automobilistico internazionale, non mi baceresti? Non mi baceresti ora? Perché potrebbe non esserci una seconda occasione». Susy era ancora immobile con l’incertezza sulla mandibola pendente quando l’esplosione della fabbrica di suo padre insanguinò l’orizzonte.
Joe sghignazzò sadicamente mentre la fuoriserie usciva di carreggiata sollevando un nuvolone di polvere. Ma El Niño non era ancora fuorigioco: il killer si aggrappò al volante e riuscì a riportare le gomme sull’asfalto, mentre Stella urlava e sanguinava dal naso. Joe allora tornò a premere sull’acceleratore, ma questa volta lo scatto della fuoriserie la salvò dallo speronamento. L’insegna al neon del drive-in si stagliava tra la vegetazione, eppure lo sguardo del killer non era più rivolto alla strada, ma fisso sul volto dell’avversario, che ora lo affiancava sulla corsia di sorpasso, tamponandolo di lato, mentre il duello raggiungeva l’apice della velocità. El Niño voleva vederlo in faccia, il becco, voleva vedere la sua paura nell’istante in cui avrebbe tirato il freno a mano.
Susy non scoppiò a piangere né si mise ad urlare, ma il fiato le si fece corto, e Rupert la sentì appena, quando gli ordinò di portarla alle Manifatture Smith. Subito. Anche da quella distanza, si capiva che le proporzioni dell’incendio erano disastrose e che le fiamme non potevano che provenire dallo stabilimento del padre di Susy. Per la prima volta Rupert vide davanti a sé quel destino manifesto di cui parlavano le antologie, sentì che una mano misteriosa gli offriva l’insperata possibilità di essere un uomo, di guidare finalmente da uomo, così trovò l'insperata forza di guardare la ragazza negli occhi e di esclamare: «Non ti preoccupare, piccola! Andrà tutto bene.» E roteando il volante col solo palmo sinistro, come se non avesse fatto altro per tutta la vita, uscì dal drive-in in retromarcia, fece fischiare le gomme nel bel mezzo della strada, e si preparò a piegare l’acceleratore a tavoletta. Ed il motore non morì, la marmitta non sbuffò, le marce entrarono una dopo l’altra, lisce come l’olio, mentre Rupert lanciava la macchina di suo padre al massimo delle prestazioni. Gli sarebbe stata sufficiente una manciata di minuti per raggiungere lo stabilimento della Smith, se il frontale con la motrice di un camion lanciata in contromano non l’avesse ammazzato sul colpo.
Dopo il freno a mano tirato all’improvviso, i tre testacoda successivi e la stridente mancia di gomma lasciata sull’asfalto, la prima immagine che Stella riuscì a distinguere davanti a sé fu la motrice di Joe. Ferma a cinquanta metri dalla Porsche di El Niño, e completamente circondata dalle fiamme. El Niño allora si spolverò la spalla destra, e rimise in moto, fermandosi per un istante di fronte alle carcasse incandescenti della motrice e della Buick bianca. «Dio mio!» disse Susy tra le lacrime, «c’erano due ragazzi, su quell’auto!».
«Non ci pensare. Sarebbero morti comunque», rispose tranquillamente El Niño, «ammazzati dall’aria condizionata». Susy si asciugò le lacrime. Lontano, ma non troppo, le sirene avevano ormai iniziato ad urlare.
«Che cosa faremo, ora?»
«Al drive-in danno Casablanca.»
«L’ho già visto… con Joe.»
«Allora battiamocela. Dicono che Tijuana sia bellissima, in questa stagione, ed è a sole duemila miglia da qui.»
L’auto imboccò l’autostrada, e fissando le linee tratteggiate perdersi nell’indistinto orizzonte notturno, ascoltando i motori e seguendo le scie evanescenti dei fanalini di coda di anime perdute sopra un fiume d’asfalto, Susy comprese che non aveva la minima idea di dove la strada la stesse portando. E per questo, per la prima volta, ringraziò Dio.
Babel Rivisitata da Francesco Spinelli
Babel: cover by *Galhad on deviantART
Francesco Spinelli ha re-immaginato la copertina di Babel per l'edizione corrente del concorso Subway Letteratura. Potete vedere le copertine qui e qui.
sabato 18 aprile 2009
Racconti Macabri: Abissi
[Pdf]
I.
Lasciati alle spalle la porta occidentale della città santa di Q’zar. Cammina per tre giorni e tre notti verso il tramonto: troverai il silenzioso deserto, il lungo crepaccio, e infine, la misteriosa morte. Quanto alla leggenda, l’avrai già trovata tra le mura di Q’zar.
La leggenda è estremamente chiara nel riferire fatti che nessuno potrà mai confermare. Parla di un crepaccio che divide le sabbie e di cui non si scorge la fine; di un guardiano immortale e spietato; di un abisso in cui si precipita per sempre.
Cammina lungo l’orlo del crepaccio: in principio è poco più che una linea nera che vomita formiche rosse; ma dopo alcuni giorni di viaggio, lo vedrai crescere in larghezza e profondità, fino a diventare un burrone del quale non potrai scorgere il bordo opposto, né immaginare la profondità. Incontrerai, allora, il guardiano.
Vedere questo jinn è impossibile, udirne la voce, inevitabile. Con parole suadenti o minacciose, sarai costretto o persuaso a muovere due passi verso l’abisso. I tuoi occhi conosceranno la voragine. Il tuo panico supererà ogni vertigine; sarà la più pura sensazione della morte, in cui la repulsione si mescola a un’invincibile attrazione. Nessuno, giunto a quel punto, resiste oltre. E anche tu muoverai il terzo passo, quello finale. Il tuo corpo non smetterà mai di cadere nel vuoto, e anche dopo che sarai morto, le tue ossa continueranno a precipitare in eterno.
Nel tempo la leggenda ha spinto occultisti, santi, eccentrici, diesperati, aspiranti suicidi, appestati, e semplici creduloni, a lasciare Q’zar per guadagnare il crepaccio. L’immortalità, il potere, il paradiso: alcuni vaneggiano di questi e altri premi per chi riuscirà a vincere la tentazione del jinn. Ma nessuno fa mai ritorno dalla voragine, nessuno conosce la fine dell’abisso né l’origine della leggenda.
II.
Broadway. Una finestra al cinquantacinquesimo piano del Woolworth Building. Cornici: quella in acciaio della finestra, quella in alluminio di un computer portatile, quella in mogano di una fotografia in bianco e nero. Una scrivania di betulla.
Jessie Metz stringe la mano al cliente; gli fa dare uno sguardo dalla finestra, vista spettacolare quanto pericolosa, commenta. Come sempre. Il cliente combatte per un attimo contro il suo stesso sguardo: cedere alla tentazione di guardare di sotto, le linee rette del grattacielo, il loro sconvolgente restringimento verso il basso, la convergenza verso un punto di fuga negato, annullato dall’impatto con l’asfalto, e poi puntini gialli e grigi, automobili e persone come microbi nell’infezione fulminante della vertigine – oppure – oppure non abbassare gli occhi, fingersi dèi, restringere il campo visivo all’azzurrità del cielo, al delirio d’onnipotenza dello skyline newyorkese, scintillante, come se non portasse i segni di una mutilazione orrenda…
Metz gli offrirà da bere, se vuole, poi lo farà accomodare. Non parleranno subito di soldi, naturalmente. Metz gli racconterà una storia logora e confortevole come una vecchia giacca di panno. Parlerà prima della finestra, poi delle azioni, e infine della fotografia.
Tacerà il prezzo della sua vista su Manhattan, ma lascerà intendere che l’acquisto di quell’ufficio è il lavoro di una vita che non è iniziata nella bambagia. Non si dilungherà sui buchi sotto le scarpe da ginnastica dell’infanzia, ma enumererà i suoi pacchetti azionari più forti: Google, Apple, Samsung – su quelli in perdita potrà sorvolare agevolmente, grazie all’aggiornamento in tempo reale delle quotazioni. Poi lancerà un’occhiata all’uomo nella cornice di mogano; nella fotografia in bianco e nero è seduto ad una scrivania pesante, ingombrata da una ponderosa macchina da scrivere. Alle sue spalle, una finestra ben riconoscibile. Metz indicherà l’uomo come suo nonno e l’ufficio come il suo. Parlerà della sua rapida fortuna e immediata rovina nel 1929. Aveva perso tutto, incluso il prestigioso ufficio in quello che era all’epoca il più alto grattacielo del mondo, e che ora il nipote ha riconquistato.
Il cliente non ha nome né volto. Non è nemmeno un uomo, ma una serie discreta di cifre, dollari e appuntamenti, una statistica che Metz ha raffinato per anni. Nove volte su dieci, dopo aver sentito la storia di Metz e di suo nonno, il cliente lascia l’ufficio con una sorta di sollievo, una ritrovata fiducia in qualcosa che pensava perduto e che invece Metz incarna alla perfezione. Nove volte su dieci, il cliente firma il contratto. Poi, un’ultima occhiata a quella finestra aperta su tutta l’America, una stretta di mano, e la porta che si chiude alle sue spalle.
Solo un cliente su venti, forse trenta, non firma perché crede che la storia di Metz sia inventata. Potrebbe benissimo esserlo. L’ufficio potrebbe essere in affitto, la foto, acquistata per un pugno di cent al mercato delle pulci. Non è così.
L’importante, in fondo, non è che il cliente creda o meno alla storia. Ma che non venga mai a conoscenza di tre fatti: che i vetri della finestra “spettacolare quanto pericolosa” furono infranti il 28 ottobre 1929; che attraverso quei vetri il nonno di Metz si tolse la vita in un lunedì nero; e che, con tutta probabilità, lo stesso farà il nipote, dopo che avrà perso tutto.
III.
Vedo che lei vorrebbe domandarmi di mio marito. Esita, però. Sa che Franz è un uomo famoso; immagina che mi vengano più spesso rivolte domande su di lui che su me stessa. Come se fossi condannata a sparire nel cono d’ombra della sua celebrità, non essere più considerata una donna, ma solo la moglie di.
Sì, a volte è esattamente così. Ma non si preoccupi. Non mi dà alcun peso parlare di Franz. Forse perché siamo così diversi, o lui, per me, rimane lo stesso ragazzo che ho sempre conosciuto. Non era certo famoso, all’epoca. Tutto il contrario.
Comunque, devo dirle che io non ho mai amato la montagna; la sorprenderà, questo non ha influito sul nostro matrimonio. Del resto saprà che Franz scala esclusivamente in solitaria. Né l’ho mai trattenuto dal partire per le sue imprese, fossero le Alpi o le Ande o il K2… lui ha i suoi spazi, io i miei, lei mi capisce.
Il fatto è che la montagna… l’umidità della foresta, poi la vegetazione che si dirada… diventa quasi meschina, poi scompare quasi del tutto… e infine l’aria sempre più rarefatta, l’acqua che diventa ghiaccio, il freddo pungente, il sole accecante… ecco, per alcuni è una specie di cammino verso la purezza, verso Dio, non è così? Per Franz certamente è così, anche se non lo definirei certo un religioso. Ma per me, oh no. A me sembra un cammino verso la morte. Ci pensi: ogni passo lungo la salita è un progressivo allontanamento dalle città, gli uomini, gli animali, gli alberi… la vita!
E io invece voglio vivere. Io amo vivere.
In un uomo apprezzo la profondità dello sguardo, la reticenza… e – lo ammetto – la forza fisica. In Franz queste caratteristiche sono portate all’esasperazione. Tante volte ho provato a chiedergli il motivo di tutti i suoi sforzi. L’allenamento sfibrante, i numerosi rischi, la sete di conquistare vette sempre più alte, imprese sempre più estreme… inoltre, lo sa, non è più un ragazzino… e tutto questo per arrivare sulla cima di una montagna! Lei non può immaginare quante volte gli ho domandato perché. E lo sa cosa mi ha risposto? Cosa mi ha risposto ogni singola volta? «Per guardare di sotto.»
Per guardare di sotto! Si figuri. Beh, qualunque cosa veda da lassù, di certo non lo saprebbe raccontare a parole. E del resto, riuscirei mai capirlo? Quello che so è che quando mi affaccio nei suoi occhi – ed è una vista insostenibile, a volte – veramente mi sembra di sporgermi in un abisso. Insondabile.
Ecco, mi dico allora. Ecco un uomo che non morirà tranquillamente nel suo letto.
martedì 7 aprile 2009
Websitehorror su Radiodeejay

Stasera alle 20.35 cinque minuti di Websitehorror su Radiodeejay con Laura Antonini.
sabato 4 aprile 2009
Quattro Chiacchiere con Matteo Grimaldi su Sololibri.net

Matteo Grimaldi, che ringraziamo, ha intervistato Hector Luis Belial per la sua rubrica settimanale 4 Chiacchiere (contate). Potete leggere l'intervista qui.
mercoledì 1 aprile 2009
Racconti Macabri: la Moneta, la Chimera, la Morte
Non è un pesce d'aprile ma un nuovo trionfo della morte, per tutti gli amanti del genere... [Pdf]
Questa terra desolata fu, un tempo, il regno più esteso della terra. Aveva inizio dal più estremo lembo di terra orientale, e terminava, assieme al mondo, sulle sponde dell’oscuro oceano dell’ovest. L’incandescente occhio del cielo impiegava un dì ad abbracciarlo nella sua interezza; ad un occhio umano, un’intera vita non sarebbe stata sufficiente.
Abbiamo dimenticato il nome, ma non l’impresa, dell’uomo che volle attraversare il regno a piedi. L’iconografia tradizionale ce lo tramanda già vecchio, povere vesti sulle spalle ormai curve, la sconosciuta fronte contro il sole che muore. Il giovane figlio, pochi passi più indietro, lo segue nel cammino. Del viandante sappiamo poco: lo sospettiamo vedovo; assumiamo che i suoi possedimenti, abbondanti o scarsi che fossero, se li fosse lasciati alle spalle, assieme alle natie coste dell’estremo oriente. Presa l’antica via che porta alle acque in cui il sole riposa, camminò per tutti gli anni che gli rimanevano, senza per questo raggiungerle. Alla sua morte, il figlio proseguì il viaggio per lui, portando con sé le ceneri paterne in un’urna di bronzo.
L’estensione del regno e l’abnegazione del suo popolo erano, in quel tempo, pari soltanto alla sua famosa prosperità. Dalla più remota antichità, ogni suddito sopra i quindici anni era – prima ancora che contadino, scriba, sacerdote – un fiero soldato del Re. Le antiche guerre erano state numerose, i bottini copiosi, la vittoria, costante. In seguito, per sette generazioni non si era udito il clamore della spada contro la spada, né dell’oscura campana che suona a peste o a carestia. La pace restava salda, la terra, verdeggiante. Né l’invasore osava violare il confine, oltre il quale l’attendeva il più vasto esercito sotto questo cielo.
I battenti del porto più occidentale della terra erano solidi, oscuri e finali; e dovettero passare innumerevoli inverni prima che un anziano viandante vi giungesse di fronte. Attraversata l’ultima porta dell’ultima città, l’uomo guadagnò l’ultima cattedrale prima del mare; lì depose tre urne di bronzo: le ceneri di suo padre, del padre di suo padre, e del padre del padre di suo padre, il quale era partito, un giorno, dalla punta più orientale del regno. Nei dipinti il viandante che giunge all’ovest non appare differente da quello – suo avo – che era partito dall’est: si tratta dello stesso viaggio, e quindi, del medesimo viaggiatore.
In quei giorni d’abbondanza viveva un grande profeta, le cui doti di preveggenza, fonte di consiglio prediletta dal monarca, erano note fin oltre i mari e i deserti.
Ebbene, egli fu colpito da una visione tanto dolorosa da renderlo, in un solo istante, infermo e cieco. Prima di spirare dolorosamente, pronunciò un’ultima profezia. Fu l’epitaffio di un’epoca.
Udite le tremende parole, il Re convocò d’urgenza i potenti del regno – ministri e sapienti, generali e sacerdoti, consiglieri e filosofi – nel futile e disperato tentativo di cambiare la sorte. In seguito a quel conclave, le teste sarebbero iniziate a cadere, ed il regno, a declinare.
Il profeta aveva annunciato che il regno sarebbe crollato per mano della pazzia. Ma che cos’era la pazzia? Come vincerla? Gli atti del gran convegno sono da lungo tempo perduti, o forse criptati in maniera tanto accurata che la chiave è ormai irrecuperabile. Ricordiamo la versione, grandemente banalizzata, che fu diffusa tra il volgo.
Il giudice sostenne che non c’era atto di pazzia che non portasse a trasgredire la legge con il furto, l’assassinio, il dolo, il tradimento, e così via; la cura era l’applicazione rigidissima del codice. Per il generale, la pazzia negli atti ingiustificati ed ingiustificabili; soldati che disertavano urlando, si denudavano in pieno giorno, si seviziavano da soli. Atti come questi, non sempre illegali, mettevano a repentaglio il controllo sul milite e sulla guerra; non nascevano dalla ragione né dalla ragione potevano essere sanati. Meglio allora il patibolo. Secondo il consigliere, una mente che mirasse ad un fine più grande del bene immediato e del senso comune poteva, talvolta, agire contro la legge e la logica apparente. Si rischiava dunque di confondere la pazzia con il segno del genio. Il sacerdote aggiunse che a volte il volgo scambiava per pazzia i segni della preveggenza e della santità; quanti profeti, nel corso dei millenni, erano stati ammazzati tra il pubblico ludibrio? Due medici non riuscirono a trovarsi d’accordo sull’ubicazione della pazzia: il cervello, oppure il cuore? Per il filosofo, la pazzia era stata distribuita ad ogni uomo, in porzioni non quantificabili né distillabili dagli altri umori che ne compongono l’essenza. A queste parole, tutti gli astanti gridarono all’oltraggio: se così stavano le cose, ogni uomo era un pazzo, e così anche il Re; c’era dunque da disperare nella salvezza del regno.
Il Re concluse che la pazzia era un’indefinibile chimera in cui lo sguardo di ciascuno riconosceva una bestia diversa. Abbracciando una definizione ed escludendo le altre, rischiava di perdere il regno. Meglio allora lasciare che ciascun suddito scandagliasse il prossimo alla ricerca dei segni della pazzia. Qualora li avesse trovati, per decreto, era da quel momento in avanti tenuto a denunciarlo all’autorità. Discusso il caso, se il giudice si fosse trovato d’accordo con l’accusa, si sarebbe proceduti al taglio della testa dell’imputato.
La legge, entrata in vigore seduta stante, portò nei tribunali un numero inusitato di accusati. La marea di presunti folli fu tale che la giustizia ne venne presto congestionata. Nella corruzione della capitale, lo scambio d’accuse di malattia mentale divenne strumentale, popolare, frequente e reciproco tra il nobile e l’avversario politico, tra l’amante e il rivale in amore, tra il pavido e lo sfidante a duello, tra il commerciante e il concorrente, tra il figlio ereditiere ed il vecchio padre, tra il locandiere e il pensionante insolvente, tra il caporale e la recluta, tra il questuante e il signore, tra il sacerdote e l’eretico. Ogni controversia si fece motivo d’accusa; i giudici, nella speranza di disincentivare la nuova usanza, e spesso, nel dubbio di assolvere un potenziale pazzo, mietevano teste. In quel periodo tre gilde crebbero di prestigio: quelle dei sacerdoti, dei boia, e dei necrofori regali. La morte divenne e rimase per sempre la prima e più remunerativa attività della capitale.
Avvistosi del disastro, il Re emise il suo ultimo decreto: avrebbe lasciato tutti poteri al reggente, meno quello di giudicare la sanità dei suoi sudditi. Se cittadini si erano mostrati cattivi accusatori e i magistrati pessimi giudici, occorreva abolire tanto i tribunali quanto le accuse. Solo il Re, da quel giorno, avrebbe diviso il sano dal folle. Quanto ai sudditi, dovevano considerarsi tutti colpevoli fino a prova contraria, e tenuti a recarsi personalmente a palazzo per sottoporsi al giudizio regale.
Prima che la notizia raggiungesse le più remote province del regno, alle porte della capitale erano stati impilati tanti teschi umani da elevarsi in mura, torri, piramidi. Nelle luci della sera, l’ombra degli edifici macabri si stendeva per miglia e miglia. Il Re aveva così iniziato il suo logorante officio. I sudditi venivano ammessi al suo cospetto uno per volta. Il sovrano poneva loro domande volte a indagare la logica, la cognizione di causa, la fedeltà alla corona. Durante i primi anni, impiegava diversi giorni per assodare la salute mentale di un singolo cittadino, o per condannarlo a morte. Ma nel corso delle stagioni, i tempi di giudizio si contrassero; venivano processati due, cinque, sette sudditi al giorno. E con l’avanzare degli anni, il sovrano si decise a continuare il lavoro anche durante la notte. Non si alzò mai più dal seggio del potere, dove consumava pasti frugali, sonni brevi e fustigati dall’incubo osceno del suo paese in fiamme. Vista la crescente economia delle sue domande, si disse che il Re aveva iniziato a tracciare i contorni dell’oscura chimera chiamata pazzia, e che poteva riconoscerla con sempre maggiore facilità. Si sostenne, nondimeno, che il monarca fosse affrettato dalla paura dell’incalcolabilità di due numeri: quello dei sudditi ancora da giudicare, e quello dei giorni che gli rimanevano da vivere.
Nel mentre, uomini e donne abbandonavano case e raccolti, reti e imbarcazioni; la polvere di gigantesche carovane si sollevava dai quattro angoli del regno, stringendosi verso il centro in una nuvola tale da oscurare l’orizzonte. Molti partivano sapendo che non avrebbero vissuto abbastanza per vedere le candide mura della capitale. Ciò non aveva nessuna importanza: sarebbero stati i loro figli a giungere al cospetto del Re e a farsi assolvere per loro.
Il sovrano aveva intanto ridotto i tempi di un processo ad un singolo istante. Ora non rivolgeva più alcuna domanda all’imputato: si limitava a guardarlo fissamente negli occhi. Poi, con un cenno della testa, gli indicava la direzione da seguire. Due porte stavano alle spalle del trono: quella di destra portava all’uscita dal palazzo, quella di sinistra, direttamente al patibolo. Secondo alcuni, il monarca aveva acquisito l’abilità di riconoscere i segni della pazzia nella profondità dello sguardo. Ma altrettanti sostennero che il suo giudizio era ormai del tutto casuale. Fu il disgusto per l’umanità, che in tanta parte sfilava ai suoi piedi, oppure il disprezzo per se stesso, incapace di riconoscere la mela marcia da quella sana, a gettare il Re in quel muto e sistematico delirio che gli permetteva di disporre della testa di un uomo con un singolo gesto del capo.
Il Re invecchiò e morì senza eredi, il suo volere continuò ad essere eseguito. Il popolo seguitò ad abbandonare campagne e città e ad affluire alla capitale.
Frattanto i figli di chi era stato assolto raggiungevano l’età per essere a loro volta giudicati, ed attendevano il loro turno per comparire all’ombra del trono. In quel tempo il teschio del Re fu incoronato ed appeso sopra il seggio con una corda d’oro. La sua oscillazione a destra o a sinistra, mossa dal capriccio del vento, determinava la condanna o la salvezza per l’imputato.
Dopo il teschio venne la moneta, dopo l’effige, il geroglifico. Mentre si dimenticava l’uso della scrittura, marchingegni sempre più sofisticati vennero a sostituire la mannaia nel taglio della testa. Ingegneri idrici studiarono nuovi sistemi di tubature per convogliare il sangue dei condannati dal palazzo alle porte della città. Nuovi dei furono inventati, le liturgie religiose si fecero più oscure, il titolo di necroforo, privilegio ereditario. La vita umana si svalutò fino a risultare inferiore a quella di un cane rognoso, e la perversione delle lotte di potere per il ruolo di reggente superarono ogni depravazione a memoria d’uomo.
Il tempo fece polvere del cranio regale, ed il reggente fece allora forgiare una moneta d’oro. Al recto i lineamenti dell’ultimo Re, al verso, quelli della Morte. Gli imputati continuarono ad essere convocati uno ad uno presso la sala del trono, dove un sacerdote, chino ai piedi del seggio vuoto, li giudicava col lancio della moneta. Ma l’usura delle generazioni appianò le due facce della moneta; il volto del sovrano e quelli della mietitrice sfumarono l’uno nell’altro, e quando infine divennero indistinguibili, ci si risolse a forgiare una nuova moneta. Per allora l’effige regale era stata dimenticata; per evitare il sacrilegio di falsificarla, la si sostituì con un monogramma. Quand’anche il monogramma fu consumato dall’uso, i segreti della scrittura erano ormai stati lungamente obliati dal nostro popolo. Nuovi simboli occulti fanno da allora le veci del Re, simboli che nessuno può decifrare, salvo il suo fautore.
Oggi la capitale è un informe groviglio di macerie: i suoi palazzi sono rovine, le sue strade, fogne a cielo aperto in cui lo sterco ed il sangue si mescolano indifferentemente. La superstizione spinge ancora le guardie a trasportare le teste dei condannati fuori dalle mura in rovina, e ad impilarle frettolosamente sui cumuli millenari. Ma i corpi decapitati vengono gettati al popolo, che se li litiga violentemente per divorarli. Questi miserabili, divorati dalla fame e dalle pestilenze, attendono il momento del loro giudizio in disperate ed incessanti orge di storpi. Richiamati dalle guardie, si trascinano attraverso le vie, che sono strade e fogne e lazzaretto, come cani con una gamba sola. Qualora vengano assolti dal giudizio della moneta, perdono la possibilità di essere processati di nuovo; molti scelgono allora il suicidio.
Non è possibile lasciare la città. Oltre le mura, per infinite miglia, la terra è morta, abbandonata e riarsa. Il cielo è divenuto oscuro, tanto che il punto in cui il sole sorge e quello in cui tramonta non sono che indistinti ed ipotetici rossori oltre nuvole che hanno dimenticato altro colore che quello del lutto. Selve nerissime divorano le antiche piantagioni, i fiumi straripano in paludi mefitiche, la gramigna, dove ancora cresce, scalza le pietre dalle strade deserte. Delle città non restano che pochi cumuli di sassi anneriti dalla fiamma, covi di lupi tanto famelici quanto deperiti per l’assenza di prede. I barbari hanno smesso da tempo di saccheggiare le terre oltre il confine, perché non c’è più nulla di cui fare incetta. Zolle di terra gelida e nera e senza frutto si stendono a perdita d’occhio, tempestate di teschi o di pietre taglienti. Benché i cancelli del regno siano stati scalzati e le torri di guardia rase al suolo, nessuno osa più varcare i confini. Se un viandante osasse addentrarsi nel regno, se anche non morisse per fame o per sete, lo ucciderebbe il silenzio.
Presto anche gli ultimi abitanti della capitale saranno giudicati e giustiziati. Si smetterà, allora, perfino l’uso di seppellire le teste in fosse comuni, perché non si conteranno più abbastanza braccia nemmeno per questo. Infine, un reggente ancora in fasce ed un vecchio sacerdote rimarranno gli unici esseri viventi. Il sacerdote tirerà la moneta per il bambino e per sé, ma a quel punto, che il giudizio sia di grazia o di condanna, non farà alcuna differenza. Anch’essi sono destinati a morire, e con la loro scomparsa, il regno sarà finalmente mondato dalla pazzia.
venerdì 27 marzo 2009
Saxophone Street Blues su Società dei Poeti Morti
Ringraziamo Penelope Silver, che ha recensito Saxophone Street Blues sul blog Società dei Poeti Morti.
Pubblicato da
Hector Luis Belial
alle
14:34
0
commenti
![]()
Etichette: Recensioni, Saxophone Street Blues
giovedì 26 marzo 2009
Racconti Macabri: Mistificazioni e menzogne attorno a un diamante su un teschio di platino
Su Website Horror, un nuovo racconto macabro di Hector Luis Belial.
Non ha più alcun senso parlare di For the Love of God. Il teschio coperto di platino e diamanti ha già contato i suoi ammiratori e detrattori. Schierarsi con gli uni piuttosto che con gli altri, ormai, significa scegliere tra l’ingenuità più pretenziosa ed una banalità che sfiora il paradosso. Quanto a chi si astiene, lo fa meno per ignoranza che per sdegno.
Del resto, ogni controversia etica, estetica ed economica legata a ideazione, finanziamento, lottizzazione e incanto dell’opera è già stata discussa fino alla noia. Il mondo ha avuto modo di sbadigliare a morte per l’unico eccesso che può veramente uccidere un’opera votata all’esubero: quello di notorietà.
[Continua a leggere]
sabato 21 marzo 2009
Racconti Macabri: Il Regno a Venire
Prosegue, del tutto impunemente, l'unico appuntamento al quale nessuno di noi potrà tardare... [Pdf]
Accadde – fatto inconsulto nell’Italia contemporanea – che la nota soubrette s’innamorasse di un morto. La coppia destò il prevedibile scandaletto e diede un po’ di lavoro alle mai inflazionate malelingue. Non saremo certo noi, comunque, a parlar male di un morto. Anzi va detto, né mancò di notarlo la stampa mondana più accorta, che si trattava di un cadavere di tutto rispetto. D’impeccabile eleganza, dalla
prestanza statuaria (pur nei limiti del suo stato di conservazione), la salma si distingueva non poco dalla cricca di sportivi e palazzinari che costituivano l’usuale cerchia di accompagnatori della velina. Parco nella conversazione, la sua idiosincrasia per lo sproloquio costituiva un caso più unico che raro. Il sontuoso matrimonio fu allestito in tempi record.
Certo, nei primi tempi, a vederlo a spasso con la giovane sposa, faceva sensazione. I paparazzi non gli davano tregua, ma egli, nella tranquillità d’animo che lo contraddistingueva, non si sottrasse mai agli obiettivi. Frustrati dall’impossibilità di coglierlo in pose che non mostrassero la massima dignità, i fotografi smisero ben presto d’inseguirlo per le strade. Nel frattempo, però, le foto della coppia in automobile avevano fatto il giro del paese, riportando in voga un tipo di vettura – il carro funebre – solitamente poco apprezzata fuori dalla cerchia degli addetti ai lavori. L’autofunebre (specie se di fabbricazione tedesca) divenne, per qualche tempo, più popolare del SUV. Dapprima status symbol del bel mondo, non mancò di affascinare anche le casalinghe, le quali scoprirono, nell’ampio bagagliaio, un incomparabile aiuto nelle compere di tutti i giorni.
Poi, inevitabilmente, si iniziò a vedere nell’inedita coppia qualcosa di raccapricciante, ovvero il cattivo gusto della velina. La quale, nella sua usuale frivolezza, insisteva nel voler trascinare il dignitosissimo morto in ambienti ch’egli non poteva non sentire alieni: il club di grido, la boutique di Gucci, la beauty farm (le cui lampade regolarmente fallivano nel risuscitarne il colorito), il ponte dello yacht dell’amico, e via dicendo. Per la verità, tutti si erano ormai resi conto che l’impeccabile contegno del defunto era del tutto incompatibile con quello, banalmente sciatto, della ballerina. Si malignò molto sul fatto che, tra le molte virtù del marito, ella non apprezzasse che il rigor mortis. Il decadimento della sciacquetta, che già da mesi si dedicava a tempo pieno alla più plateale cornificazione del defunto, coincise con l’inizio della nuova stagione televisiva.
Epurata dai palinsesti, privata anche dell’ultima colonna di giornaletto da teenager in cui lamentarsi della freddezza del marito, seguitò per qualche tempo nelle sue tresche via via più squallide – il sedicente produttore cinematografico, l’imprenditore, il salumiere, il venditore d’auto usate, l’idraulico, il testimone di Geova, la centralinista del call center della carta di credito bloccata… Fallendo nel rompere l’oblio in cui il suo nome era stato gettato, sfiorita al punto da essere rifiutata ai provini di un film porno, ottenne il divorzio dal morto e tornò a vivere dalla madre.
La fortuna del morto, di contro, non accennò a scemare. Anzi l’interesse per il cadavere aumentò di prestigio: dalla cronaca rosa passò a quella politica. Ma questo morto sarà di destra o di sinistra? La domanda serpeggiava in seconda serata e nei corridoi di palazzo. Astensinista, democristiano, trasformista, bipartisan – ognuno interpretò il silenzio del morto a modo suo. Su una cosa si trovarono tutti d’accordo: sembrava il leader di partito ideale.
Carismatico, inflessibile, più ben conservato che buon conservatore, il suo humour era esclusivamente nero. In compenso, si trattava indubitabilmente di un uomo tutto d’un pezzo. Il personaggio adatto a riportare la serietà nell’arena politica italiana. Perfino senza un profilo su Facebook o dei video su Youtube, il morto era proiettato nel futuro – il futuro di tutti! – come nessun altro. Specchio ideale dell’elettore medio, il morto fu accolto in Roma da cortei e corone di fiori. Esordì impeccabilmente al Ministero della Cultura. Non sappiamo ancora quando, ma è ormai una certezza universalmente nota: il suo governo verrà. E, presumibilmente, non avrà fine.









